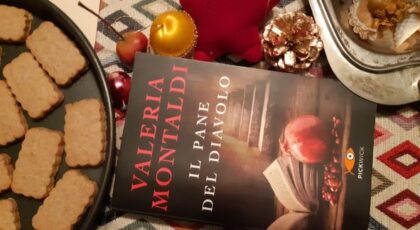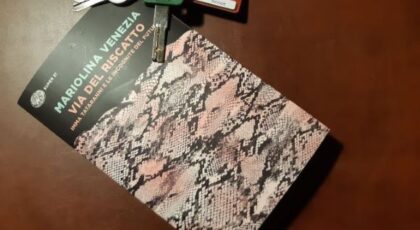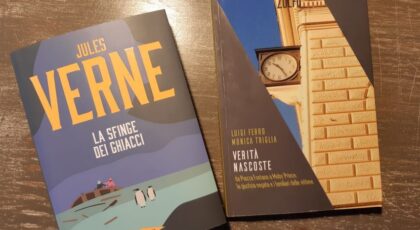«Romanzo russo», autore Alessandro Barbero, riedito da Sellerio nel novembre 2024, pp. 684 (prima pubblicazione 1998, Mondadori).
In una frase: libro impegnativo e generoso di soddisfazioni per il lettore.
Nel corso di una presentazione di questa fresca seconda pubblicazione del suo «Romanzo russo», Alessandro Barbero ha raccontato di aver avuto, verso la fine del secolo scorso, un’ispirazione che non esita a definire «demenziale se ci penso adesso», e cioè quella di realizzare un romanzo sì «russo», con impianto narrativo, personaggi e luoghi russi, ma ricalcando «esattamente la trama de «I promessi sposi».

«Romanzo Russo», ambientato nell’Unione Sovietica di Michail Gorbaciòv, tra il novembre del 1987 e il febbraio del 1991, ha un numero di capitoli in effetti identico a quello del capolavoro manzoniano e la narrazione vera e propria, come avviene per «I promessi sposi», è preceduta da un prologo in cui si descrive il ritrovamento «di un manoscritto che nessuno conosceva. Era un grosso pacco di fogli extrastrong, battuti a macchina a spazio uno, in duplice copia, ben protetti nel loro imballaggio di cartone. Non c’era il nome dell’autore, né il titolo». (p. 13); il lettore del misterioso manoscritto diventa la voce narrante, in prima persona, della storia, ma premette: «soprattutto ci tengo a chiarire che non l’ho scritto io, il maledetto romanzo; io, anzi non voglio proprio averci a che fare, di me non sentirete più parlare». (p. 15).
Il primo personaggio che si presenta al lettore (il Don Abbondio di Barbero, se vogliamo) è il professor Obilin, direttore dell’Istituto di Storia del Pcus (Partito comunista dell’Unione Sovietica) all’Università Statale di Mosca, cioè il docente con il quale la protagonista femminile del romanzo, Tanja Borisovna (che non deve sposarsi) sta portando a termine la sua tesi di dottorato e il titolo della tesi, approvato a suo tempo, Obilin, risente dell’aria nuova che si respira da qualche tempo in Unione Sovietica: «I quadri del partito nella regione di Bakù tra 1949 e il 1953».
Prima della Perestrojka (liberalizzazione, apertura, trasparenza) e della Glasnost (ricostruzione), parole simbolo del programma politico di Gorbaciòv fin dal 1985, sarebbe stato infatti impensabile studiare «QUELL’argomento e QUEGLI anni (dal 1949 al 1953, hai detto niente! Anni di cui pure nei manuali, Obilin lo sapeva per esperienza personale, si parla in gran fretta e senza scendere nei dettagli: avanti al galoppo, verso lo Sputnik e il volo di Gagarin, lì sì che si respira, finalmente…)». (p. 33). Nel 1953 era morto Josif Stalin, dopo aver esercitato il potere assoluto in Unione Sovietica, ininterrottamente, per quasi trentun anni.
Il professor Obilin non è uno stupido; è meschino e sfortunato, di quella sfiga alla Fantozzi, per capirci, e proprio a lui, in quel gelido novembre moscovita del 1987, capita di ricevere la visita inaspettata di «due ometti baffuti», apparentemente insignificanti e provenienti, guarda caso, da Bakù. Sono due funzionari di partito che gli chiedono di fermare la tesi di Tanja («Questa tesi non s’ha da fare, né domani né mai!», avrebbero detto i bravi). I due figuri dapprima provano a blandire il professore, quindi tentano di corromperlo, finché uno sbotta: «Obilin, lo capisci il russo? Non ficcare il naso negli affari nostri!» e poi: «Cacciò la mano in tasca, ne estrasse un pomodoro maturo, allungò un braccio sopra la scrivania fino a un pacco di bozze corrette, e lì, con determinazione, spiaccicò il pomodoro; quindi, sempre fissando Obilin, gli afferrò la cravatta e ci si ripulì meticolosamente le dita rosse di sugo». (p. 37).
Di paralleli altrettanto evidenti tra «Romanzo russo» e «I promessi sposi», non ne ricordo altri; la struttura narrativa di quest’opera è costituita dall’intreccio, riuscito benissimo, di tre storie, in partenza distinte e distanti, che poi sorprendentemente confluiscono. La realizzazione della tesi di Tanja è la prima, poi c’è l’ossessione malinconica di Mark Kaufmann, un attore di famiglia ebrea, che continua a lavorare a un romanzo dedicato alla deportazione e allo sterminio degli ebrei di Odessa, avvenuto tra il 1941 e il 1944, infine il racconto dell’indagine sul misterioso omicidio di un ayatollah: «Pasaev, presidente del Consiglio Islamico di Transcaucasia, il religioso più influente della Repubblica sovietica d’Azerbaigian, sgozzato in mezzo alla strada» a Bakù (p. 244). Incaricato dell’indagine è il giudice istruttore Nazar Lappa, le cui funzioni assomigliano a quelle di un nostro pm: «Nazar, benché fosse laureato in giurisprudenza, si distingueva dalla maggior parte dei giuristi, perché non credeva affatto alla sacralità della legge, e nemmeno, si capisce, al socialismo; eppure il suo lavoro gli piaceva lo stesso. Bé, mi par di sentirvi: con tutte le bustarelle che si prendono in quei posticini! Invece, il giudice Lappa non aveva mai preso un soldo in vita sua. No, lui era proprio di quei giudici cui si riferiva quel tale: a loro piace giudicare, come al falegname fare i mobili e all’attore recitare …». (pp. 107-108).
Il romanzo funziona alla grande; la complessità del testo, a cominciare dalla difficoltà tipica dei nomi propri russi, non deve scoraggiare: i personaggi sono caratterizzati in modo esemplare (tipico nella letteratura russa), gli episodi divertenti sono molti e la vena ironica nella scrittura di Alessandro Barbero rilassa e conforta.
Finale: «Romanzo russo.», oltre alla trama avvincente e in alcune parti molto emozionante, dà al lettore una straordinaria rappresentazione dal di dentro delle idee e dei sentimenti che pervadevano (e magari sono rimasti immutati) i diversi strati della popolazione dell’Unione Sovietica in un decennio, che per noi occidentali sembrava il miracoloso lieto fine di una favola, con l’immancabile «e tutti vissero felici e contenti».
Capire quel periodo può quindi aiutare a decifrare meglio l’oggi, e a individuare alcuni dei motivi del perché le nostre grandi speranze di allora si sono rivelate perlopiù fragili illusioni.